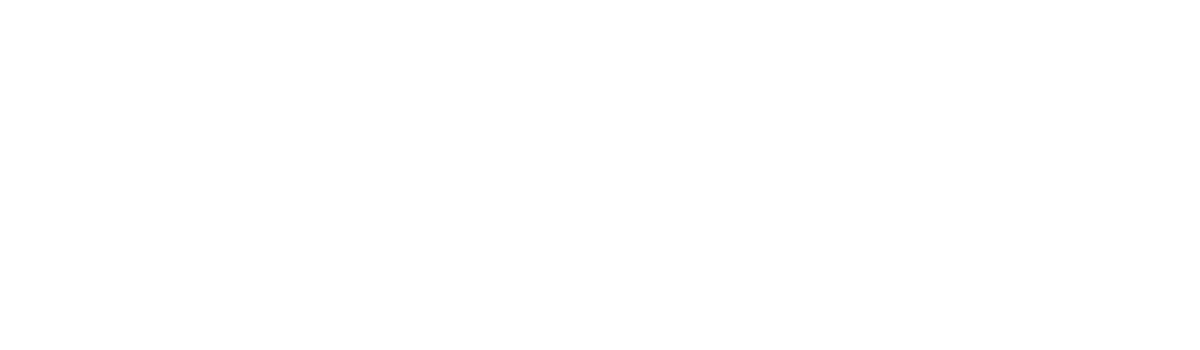All’inizio della pandemia di Covid-19, le economie avanzate stavano entrando in una nuova era: l’era della “magic money”. Questa è l’opinione di Sebastian Mallaby, attualmente Paul A. Volcker senior fellow for International Economics presso il Council on Foreign Relations espressa sulla rivista “Foreign Affairs”. L’inflazione sembrava dormiente e le banche centrali non erano state penalizzate per aver creato denaro dal nulla. Tutto questo flusso di denaro mantenne i tassi di interesse vicini allo zero e per questo i governi non avrebbero subito alcuna penalty facendo debiti prendendo a prestito da banche centrali accondiscendenti.
Si andava affermando, cioè, un periodo di politiche ultra-espansive. Le nazioni con i prezzi saldamente frenati ebbero il potere di aiutare i loro cittadini con misure straordinarie, grazie alla “magic money”.
Recentemente, il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, il 16 marzo, ha annunciato, dopo lunghe tergiversazioni, che la banca centrale avrebbe aumentato i tassi di interesse di uno 0,25%. In modo informale gli ambienti attorno banca centrale però alludono ad ulteriori, ripetuti interventi di 50 punti-base ciascuno per cominciare a stroncare un’inflazione per nulla temporanea e decisamente più veloce di questi interventi. La speranza sembra essere quella di fermarsi ad un 3,5% a fine anno.
In un altro interessante articolo pubblicato su “Foreign Affairs”, Gian Maria Milesi-Ferretti, senior fellow presso l’Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy presso la Brookings Institution e, in precedenza, vicedirettore di ricerca del Fondo Monetario Internazionale, analizza le prospettive che si aprono a livello mondiale, partendo dalle decisioni prese negli Usa. L’autore sottolinea che dall’inizio dell’anno, il presidente della Fed e i suoi colleghi hanno soltanto annunciato aumenti dei tassi a breve e altre “misure necessarie” per ridurre l’inflazione, pur risultando evidente l’indilazionabilità delle misure restrittive.
La questione riguarda, allora, la diagnosi delle cause di questa inflazione “inattesa” dato che si comincia ad ammettere la responsabilità della politica fiscale e monetaria troppo espansive: ovvero bassi tassi di interesse e ingenti quantità di spesa pubblica “corrente”, cioè costituita in particolare da trasferimenti alle famiglie. Queste scelte furono notoriamente legate ai fattori specifici della pandemia e ad esse si aggiunsero le interruzioni delle catene logistiche globali e, infine, l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei manufatti e più recentemente lo scoppio della guerra in Ucraina. Il quesito diventa pertanto questo: gli aumenti pianificati dei tassi di interesse in che misura ridurranno la crescita economica? E la crescita economica di quali paesi?
Qualunque sia il loro impatto – scrive Milesi-Ferretti – l’aumento dei tassi di interesse non riguarderà solo gli Stati Uniti. Tassi Usa più alti rendono il credito in dollari sui mercati internazionali più costoso. Secondariamente, essi fanno crescere la domanda di asset americani in dollari con la conseguenza di una rivalutazione della valuta Usa rispetto ad altre monete. Ecco dunque un altro problema per le nazioni il cui debito con l’estero è denominato in dollari, il cui rimborso diventerà anch’esso più costoso.
Molti di questi paesi hanno accumulato montagne di debiti negli ultimi dieci anni quando l’inflazione e i tassi di interesse erano bassi e negli ultimi due anni quando affrontarono i costi legati al Covid-19, hanno scritto Yuka Hayashi, Jason Douglas e Chao Deng, il 17 aprile 2022 sul Wall Street Journal.
È ovvio dire che le conseguenze di queste misure monetarie produrranno effetti asimmetrici, gravando di più sui paesi a basso e medio reddito. Infatti, rispetto agli stati più ricchi, queste nazioni hanno spesso un grado di affidabilità peggiore e pertanto il credito richiesto diventerà più oneroso, pur essendo essi più bisognosi di altri di finanziamenti esteri.
Per di più, gli sforzi per aiutare i paesi debitori in difficoltà – dicono Yuka Hayashi, Jason Douglas e Chao Deng – sono divenuti complicati per l’ingresso, negli ultimi anni, di creditori nuovi e meno esperti nei prestiti ai paesi in via di sviluppo. Cercando di ottenere migliori rendimenti in un mercato con bassi tassi di interesse, gli investitori internazionali tra cui fondi pensione, private equity ed enti finanziari hanno accumulato titoli di debito pubblico ad alto rendimento ed oggi alto rischio.
Tra essi, curiosamente, secondo l’Fmi, la Cina la cui quota del debito estero dovuto dalle 73 nazioni povere altamente indebitate è balzata al 18% nel 2020 dal 2% del 2006, mentre i prestiti del settore privato sono saliti all’11% dal 3%.
L’impatto negativo, dunque, colpirà le economie in via di sviluppo ed emergenti che sono tuttora afflitte dalle ricadute economiche della pandemia. Ci sono poi altre nazioni che sono importatrici nette di prodotti alimentari e di energia, i cui prezzi sono aumentati drammaticamente in conseguenza della guerra in Ucraina. È quindi molto probabile che questi paesi manifestino una maggiore sofferenza per il loro debito estero e siano costrette, pertanto, a forti svalutazioni. Il tutto sarà un ulteriore ostacolo alla crescita economica e alla lotta contro la povertà già programmate.
Il dollaro è la principale valuta di riserva mondiale ed è sensibile alle azioni della Federal Reserve. L’aumento dei tassi quindi ha effetti molteplici, tra cui un impulso all’inflazione di quei paesi che sono dei forti importatori di beni e servizi pagati in dollari.
Il risultato – sempre secondo Milesi-Ferretti – potranno essere misure di austerità interna, che si tradurranno in una minore crescita economica. Per attutire gli effetti della pandemia, molti paesi più poveri dovranno accollarsi più debiti esteri in presenza di un rallentamento dell’economia. Le economie dipendenti dal turismo, ad esempio, hanno visto prosciugarsi la loro principale fonte di entrate esterne quando i viaggi internazionali si sono fermati. Anche molte economie emergenti e in via di sviluppo stanno già affrontando l’inflazione interna, innescata da interruzioni della produzione legate alla pandemia e dall’aumento dei prezzi globali dell’energia e dei generi alimentari.
Ancor più preoccupante è proprio l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, che sono cruciali nelle economie emergenti e in via di sviluppo. I loro consumatori spendono infatti per l’alimentazione una percentuale maggiore del loro reddito rispetto agli stati più ricchi. Memori degli anni delle primavere arabe potrebbero innescarsi dei disordini sociali.
Un altro segnale dell’inasprimento della politica monetaria della Fed, è la risalita recente del tasso di interesse sui titoli del Tesoro Usa a 10 anni cresciuti di un punto percentuale. Milesi-Ferretti ritiene che “una fine rapida e indolore dell’inflazione statunitense non sia una conclusione scontata. L’inflazione statunitense ha già disatteso le aspettative, superando di gran lunga le previsioni del 2021. Se la domanda rimanesse forte negli Stati Uniti e se i loro mercati del lavoro rimanessero inelastici, l’inflazione potrebbe rivelarsi ancora più ostinata di quanto suggeriscano la maggior parte delle previsioni.”
In sintesi, l’accresciuta incertezza sfavorisce i paesi poveri e meno ricchi, poiché gli investitori tendono a ritirarsi dagli asset più rischiosi e soprattutto dagli investimenti diretti. Un deflusso di capitali dai paesi in via di sviluppo, più bisognosi di investimenti, verso gli Usa complicherebbe in negativo lo scenario economico e geopolitico mondiale.
Il riferimento è all’aumento dei tassi di interesse dall’1 % al 5,25 % tra il 2004 e il 2006. Le economie dei mercati emergenti non subirono turbolenze finanziarie, in parte perché gli Stati Uniti e l’economia mondiale stavano crescendo rapidamente. Viceversa, quando a metà del 2013, i tassi di interesse a lungo termine aumentarono di un punto percentuale, le conseguenze per i paesi in via di sviluppo furono gravi. Diminuì la domanda dei loro titoli di debito ed essi dovettero svalutare.
“In altri casi, – ricorda Milesi-Ferretti – i rialzi dei tassi hanno avuto conseguenze più notevoli. Tra il febbraio 1994 e il febbraio 1995, la Fed ha aumentato di circa tre punti percentuali i tassi di interesse a breve termine e di circa due punti percentuali i tassi di interesse a lungo termine. Gli aumenti, insieme ai fattori economici e politici interni, hanno portato il peso messicano al collasso, provocando una recessione nel paese. Il Messico alla fine ebbe bisogno di un salvataggio internazionale per scongiurare il default.”
In sintesi, gli aumenti dei tassi, dovranno, molto probabilmente, essere decisamente più alti di quanto si teorizzi oggi. Il riferimento è sempre al periodo tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, quando il presidente della Federal Reserve statunitense Paul Volcker raddoppiò i tassi di interesse, portandoli a sfiorare il 20%. Le conseguenze sul piano produttivo e occupazionale furono durissime, ma l’inflazione venne brutalmente domata. Tuttavia, come ulteriore conseguenza collaterale si ebbe anche un’ampia crisi del debito di alcune economie emergenti e in via di sviluppo e il default per alcune di loro. Tra il 1981 e il 1983, il Pil diminuì del 2,8% in Brasile, del 4% in Messico, del 7,5% in Venezuela e di un sorprendente 16% in Cile.
In uno scenario diverso, conseguente alla scomparsa dell’Unione Sovietica e la spinta ad una globalizzazione sempre maggiore, gli effetti di un aumento dei tassi potrebbe produrre effetti che oggi non sono contemplati dalle teorie più popolari e condivise. In conclusione, stiamo passando le Colonne d’Ercole per navigare in “uncharted waters”.